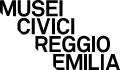LOVING FONTANESI
Inizia mercoledì 10 aprile, alle ore 18.30 a Palazzo dei Musei, il ciclo di incontri “Loving Fontanesi” per approfondire i temi della mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri” con l’intervento dei curatori e di specialisti delle diverse tematiche affrontate.
Al termine delle conferenze sarà possibile visitare la mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri” con accesso gratuito.
10 aprile – Elisabetta Farioli “Fontanesi e la sua città: storia di una riappropriazione”
In occasione della mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri” Elisabetta Farioli, direttrice dei Musei Civici, dedica una serata di approfondimento al tema “Fontanesi e la sua città: storia di una riappropriazione”.
Il tema del primo incontro sarà il rapporto di Fontanesi con la sua città, nei primi trent’anni della sua vita, dal 1818 al 1848, e poi, dopo la sua morte, nel tardivo riconoscimento che Reggio Emilia fa del suo artista più importante.
A Reggio Emilia Antonio Fontanesi non riceve nei primi anni particolari riconoscimenti: impegnato come decoratore in alcune case della città, scenografo per il Teatro Municipale, non riesce a ottenere la cattedra alla scuola di belle arti, il Comune gli nega la disponibilità di uno studio gratuito, il suo patriottismo lo rende sospetto alle autorità. “Nemo propheta in patria ” rimane anche durante la vita; a parte i suoi contatti con gli amici più cari, la città sembra indifferente ai suoi successi artistici. Un breve trafiletto riportato dai giornali torinesi ne segnala la morte nel 1882. Bisogna aspettare i riconoscimenti nazionali, a partire dalla biennale di Venezia del 1901, per registrare in città un primo interessamento per la sua arte, ad opera soprattutto di due artisti, Augusto Mussini e Giovanni Costetti e poi di Naborre Campanini, direttore del museo, impegnato nel seguire in prima persona l’esecuzione del monumento a Fontanesi donato da Leonardo Bistolfi alla città di Reggio. Ma la definitiva riappropriazione di Fontanesi da parte della sua città natale si ha solo nel 1949 con una grande mostra allestita presso il Teatro Municipale, segnalata su tutti i giornali nazionali. Il nome di Antonio Fontanesi diventa il simbolo di una ritrovata identità della città.
A duecento anni dalla nascita, Reggio Emilia dedica un’ampia retrospettiva ad Antonio Fontanesi, pittore tra i più intimamente partecipi al movimento romantico europeo. La sua eredità artistica si inoltra nel Novecento, culla della modernità, ed è leggibile sino alla fine del Secolo breve.
Promossa dai Musei Civici di Reggio Emilia, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei-Galleria d’arte moderna e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, la mostra è realizzata in partenariato con la Regione Emilia-Romagna – Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia ‘Pietro Manodori’, Destinazione Turistica Emilia, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Reggio Emilia, Apt Servizi, Trenitalia, col contributo Art Bonus di Iren, Car Server, Credem.
Curata da Virginia Bertone, Elisabetta Farioli, Claudio Spadoni, l’esposizione ricostruisce attraverso le più importanti opere di Fontanesi il percorso dell’artista e intende offrire un nuovo contributo critico alla sua conoscenza.
In occasione dell’incontro l’accesso alla mostra è gratuito.
******
13 Maggio – Incontri con i curatori: Virginia Bertone
Ciclo di incontri d’approfondimento con i curatori delle diverse sezioni della mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri”.
Virginia Bertone
“La gloria rivendicata”: la grande mostra retrospettiva di Fontanesi del 1901 a Venezia”
La conversazione mette a fuoco una tappa decisiva per la riscoperta di Antonio Fontanesi, dopo che l’insuccesso dell’Esposizione Nazionale di Torino del 1880 rischiava di disperderne la memoria. Sarà a Venezia, grazie all’esposizione retrospettiva che gli fu dedicata nel 1901, che l’opera dell’artista susciterà grande interesse e si porranno le basi per la sua riconsiderazione critica. Ma attraverso quali vicende si giunse a quell’iniziativa? Chi furono gli artisti e i critici che si adoperarono per conservare la sua memoria? Quali opere riscossero maggiore successo? Tutto questo sarà al centro dell’incontro affidato a Virginia Bertone, conservatore della GAM di Torino e co-curatrice della mostra.
****
29 maggio – Tra Longhi e Arcangeli: l’eredità romantica di Antonio Fontanesi – Claudio Spadoni
La fortuna critica di Fontanesi nel secondo dopoguerra dipende soprattutto dalle letture di Roberto Longhi e del suo allievo Francesco Arcangeli che seguì, approfondendola, la traccia del maestro, nel senso di una lettura in chiave romantica di Fontanesi. Per Longhi si tratta di una delle poche figure dell’Ottocento italiano salvate dalla drastica stroncatura che lui stesso aveva fatto degli ‘adorabili ottocentisti’ italiani, confrontati impietosamente agli impressionisti francesi che egli aveva esaltato fin dalle sue dispense giovanili per gli studenti di un liceo. Longhi aveva poi scomodato per Fontanesi, (il solo capace di reggere, a suo avviso, accanto a Corot in una Biennale veneziana) nientemeno che i romantici inglesi Constable e Turner, dei quali poi Arcangeli avrebbe scritto pagine mirabili.
Arcangeli, partendo da queste premesse, mentre orienta la sua visione critica su alcuni pittori ‘padani’ definiti ‘ultimi naturalisti’, definisce Fontanesi come un loro lontano precursore, in un nuovo pensiero-sentimento della natura tipicamente romantico.
Infine, per quanto riguarda pittori come Ennio Morlotti, Pompilio Mandelli, Mattia Moreni, Sergio Romiti, ma anche Alberto Burri, il grande umbro dei ‘sacchi’ degli anni ’50, Arcangeli usa talora espressioni che sembrano tratte quasi alla lettera da quanto scritto, sempre in quel breve volgere di tempo, per Fontanesi.
5 giugno Panorama cronologico della vita di Antonio Fontanesi – Ilaria Campioli
La storia di Antonio Fontanesi si muove sullo sfondo di un secolo caratterizzato da importanti cambiamenti sociali e da significative scoperte mediche, scientifiche e tecnologiche. Sono gli anni della creazione degli Stati nazionali e delle lotte indipendentiste, dell’industrializzazione dell’Europa, dell’affermazione della borghesia e dei grandi viaggi scientifici. È un secolo caratterizzato dagli studi e dalle ricerche sulla percezione e sui dispositivi di visione: dai taumatropi fino al caleidoscopio e lo stereoscopio, per arrivare a panorami e diorami, strumenti che dominano, assieme alla fotografia, l’immaginario visivo. La conferenza illustra la vita di Fontanesi in rapporto al suo tempo evidenziando gli incontri, i momenti e gli eventi più rilevanti del suo percorso artistico.
12 giugno – Antonio Fontanesi nella letteratura artistica tra otto e novecento – Alessandro Gazzotti
Ormai quasi dimenticato, Fontanesi inizia a ricomparire nelle letteratura artistica italiana a partire dal 1892, a dieci anni dalla morte. I protagonisti del simbolismo piemontese riconoscono Fontanesi quale maestro e precursore della nuova pittura, ma sarà l’allievo Marco Calderini a consacrarlo attraverso la monumentale monografia del 1901, punto di partenza di ogni futuro studio sull’artista. Nel corso del Novecento Fontanesi sarà al centro di importanti riscoperte cui faranno seguito gli approfondimenti di alcuni dei più importanti critici, studiosi e artisti italiani: dalle letture in chiave “novecentesca” di Carlo Carrà e Margherita Sarfatti alle acute interpretazioni di Mario Soldati ed Emilio Cecchi, fino alla proposta espositiva di Roberto Longhi alla Biennale di Venezia del 1952 e a quella critica di Francesco Arcangeli che lo colloca nel percorso che va “dal romanticismo all’informale”.
19 giugno – Fontanesi e gli artisti:il rapporto con il divisionismo – Alessandro Botta
Il processo di pieno riconoscimento dell’opera di Antonio Fontanesi (1818-1882), dopo la sua morte, sarà lontano a venire. Bisognerà infatti attendere sino all’Esposizione Retrospettiva della Promotrice di Torino del 1892 per ritrovare un rinnovato interesse verso il suo lavoro, presentato nell’occasione con sessantotto opere, divise tra dipinti e disegni: una circostanza posta ormai a debita distanza dalla sventurata mostra del 1880 (occasione nella quale Fontanesi si presentava con le Nubi, senza ottenere il successo sperato), necessaria per tornare ad osservare senza pregiudizi la sua pittura, tanto da un punto di vista tecnico, quanto compositivo. Una visone tutt’affatto nuova del suo lavoro, riletta, oramai, anche attraverso la luce delle contemporanee esperienze divisioniste, che proprio sul tema del paesaggio trovavano uno dei motivi di massima espansione e ricerca.
Quanto Fontanesi potesse rappresentare per la generazione di artisti nati dopo gli anni Cinquanta (escludendo i suoi allievi dell’accademia torinese, sempre fedeli al ricordo del maestro), ben lo dimostrano le attestazioni di interesse e stima verificabili già a partire dagli anni Novanta. È in particolare il pittore Vittore Grubicy che, attraverso la sua ferma attività di critico, si fa in più occasioni portavoce dell’importanza di Fontanesi, affermando l’attualità della sua pittura anche dopo la sua scomparsa. Un interesse verso il pittore che nasceva dalla conoscenza diretta dello stesso, incontrato in occasione della Mostra postuma delle opere di Tranquillo Cremona, organizzata -proprio da Grubicy- nel 1878, presso il Ridotto del Teatro alla Scala di Milano.
Se da un lato gli artisti riconoscevano nel maestro di Reggio un precursore della tecnica divisionista, la sua pittura ben si adattava -dall’altra- ad essere interpretata alla luce della nuova concezione del paesaggio come “stato d’animo”.
Un riconoscimento verso l’artista che non si limitava esclusivamente alle parole ma che -nel caso di Grubicy e di Luigi Conconi- si estendeva a forme di collezionismo diretto: un’attestazione certa di stima verso l’artista e il suo lavoro ma anche, verosimilmente, una scelta che riconosceva nella pittura del maestro un modello di studio per le loro rispettive ricerche.
Quasi dieci anni più tardi dalla retrospettiva torinese, nel 1901, la sala fontanesiana all’Esposizione internazionale di Venezia apriva ad un interesse più ampio e, finalmente, ad un pieno riconoscimento del pittore da parte della critica “professionale”, sino a quel momento scarsamente interessata ai suoi lavori. Gli artisti, dal canto loro, non mancavano di ribadirne -ancora una volta- l’importanza, sottoscrivendo una serie di iniziative atte a rivalutarne la figura. L’artista rappresentava, infatti, un valore in grado di convogliare gli interessi di generazioni (e orientamenti) trasversali di pittori, come una sorta di riferimento imprescindibile da cui ripartire, per costituire una moderna discendenza della pittura di paesaggio in Italia.
Vai alla mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri”
Vai alle collezioni di Palazzo dei Musei
L’iniziativa è ad ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione
Info:
0522 456816 Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1
Durante gli orari di apertura della sede.
musei@comune.re.it